pv magazine Italia ha avuto il piacere di sentire Alessandro Visalli, architetto e urbanista con venticinque anni di esperienza nella consulenza ambientale, per capire cosa implicano le nuove Linee Guida dell’Ispra per lo Studio di Impatto Ambientale.
Lei ha spiegato online che l’Ispra ha terminato il suo lavoro sulle Linee Guida per lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) necessario se si intenda sottoporre a VIA i progetti Agrivoltaici. Le linee guida in questione si applicano già da ora? Come?
Direi che le Linee Guida non si applicano in senso stretto, è perfettamente lecito non essere conformi pedissequamente, anzi non è neppure ragionevole ed opportuno esserlo. Si tratta di documenti di indirizzo, non conformativi. Ma è buona prassi e motivo di favor amministrativo nel procedimento essere coerenti con esse. Sono quindi applicabili. Con due precisazioni: la prima è che si tratta di Linee Guida per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (quindi nell’ambito dei procedimenti di VIA e non, strettamente, di Assoggettabilità alla VIA), la seconda che si tratta di un documento abbastanza chiaramente disegnato con il presupposto di trattare la VIA nazionale. Quindi sono molto dettagliate ed esigenti.
Nell’attuale contesto normativo, definito dal D.Lgs. 190/2024, gli impianti agrivoltaici sono sottomessi alla procedura di Assoggettabilità alla VIA, ovvero ad un livello di elaborazione meno esigente. Stiamo parlando di impianti agrivoltaici avanzati o di tutti i progetti?
Ora, appunto, la VIA Nazionale è stata esclusa dai procedimenti, se non in casi residuali o per impianti molto grandi. La procedura ordinaria è tornata (come era prima) la più semplice procedura di assoggettabilità. Procedura che si può concludere in due modi: o con il rinvio alla VIA, o con la decretazione della Compatibilità Ambientale. Ciò detto, la procedura in oggetto è concettualizzabile come esercitata su un livello di progettazione e documentazione meno avanzato (oggi non ci sono più i progetti “preliminari” e “definitivi”), quindi molti dei termini delle Linee Guida rappresentano un appesantimento non necessariamente appropriato. Diciamo che si tratta di valutare caso per caso ed in funzione della pertinenza e rilevanza del singolo indicatore o tematismo rispetto alla situazione concreta. Riguardo alla sfera di pertinenza, si legge “agrovoltaici e fotovoltaici”, quindi, in realtà tutti.
Spiega che un gruppo di lavoro realmente interdisciplinare richiede quanto meno naturalisti, paesaggisti, agronomi, geologi, ingegneri ambientali, architetti e urbanisti. Queste competenze chiaramente sono presenti in Italia, ma così anche su tutto il territorio? Prevede difficoltà locali a reperire le competenze richieste?
In linea di massima sono presenti ovunque. Certo, l’università italiana forma un numero limitato di alcune di queste figure. Noi abbiamo assunto in pratica tutti gli urbanisti materialmente disponibili nella nostra area, nella fase di formazione dei gruppi di lavoro. Ma non vedo problemi decisivi. Avere internamente queste competenze è di fatto l’unico modo, o di gran lunga il migliore, per posizionarsi ai livelli di analisi richieste da questi documenti. Ed anche per interpretarli correttamente.
Se non sbaglio, spiega che le nuove linee guida includano alcune analisi che, nella pratica, sono molto onerose se generalizzate su aree ampie. Fa riferimento ad esempio alla caratterizzazione della flora a livello di rilievi in situ, con stazioni e periodi diversi, e la relativa analisi tecnica di vulnerabilità con redazione della Carta Tecnica della Vegetazione reale. Stessa cosa per la fauna. Cosa vuol dire in pratica per i progetti?
Come detto tutte le analisi indicate dalle Linee Guida, in generale logicamente appropriate, sono da interpretare e non da prendere alla lettera. Alcune analisi, se fatte in modo scolastico richiederebbero lo svolgimento durante almeno un anno e decine di sopralluoghi condotti con molte persone qualificate. Altre modellizzazioni sofisticate. La realtà è che possono essere sproporzionate, e quindi non pretendibili, in alcuni casi e in altri invece necessarie. Dipende da una preventiva comprensione e descrizione delle caratteristiche salienti del territorio, e del quadro normativo e descrittivo contenuto negli strumenti di programmazione, in rapporto con i fattori di pressione specifici del progetto. Per questo serve una profonda analisi interdisciplinare e poi una specifica progettazione delle indagini stesse.
Può spiegare quali sono le analisi elencate al punto 4.1.2.1.1 e seguenti? Di cosa si tratta? In quali casi saranno obbligatorie?
Le analisi che descrivono le interazioni dell’opera con l’ambiente nelle diverse fasi (di cantiere, 4.1.2.1, e di esercizio 4.1.2.2) presumono una identificazione specifica delle interferenze dell’opera (in cantiere ed in esercizio) con l’ambiente e la stima dei relativi impatti. Sono tutte espresse ad un livello molto generale, e non vanno prese in senso letterale ed enumerativo, ma come tracce ed esempi. Per cui gli “impatti cumulativi” dipendono, ovviamente, da cosa si cumula, quale è l’impatto che si verifica essere rafforzato o potenziato. Gli effetti sulle componenti floristiche, faunistiche ed i relativi equilibri richiedono la valutazione di specialisti naturalisti, i quali potranno argomentare se ci sia l’effettivo rischio di alterazione di habitat e il potenziale danno a specie (in particolare protette). Ma anche, ed è in realtà ciò da cui si parte sul piano logico (se pure nell’ordine della esposizione può venire dopo), la cosiddetta “capacità di resilienza”. Per definire questa è, di nuovo logicamente e tecnicamente, necessario avere una idea della interazione tra le diverse pressioni e delle aree colpite.
Da questo si passa, una volta definito un danno potenziale, a vedere come si può mitigare (attenzione, non compensare), ovvero come si può ridurre la sua magnitudine. Qui gli esempi sono davvero impressionanti (ad Ispra andrebbe forse fatto notare che un impianto elettrico in tensione va necessariamente recintato, non può essere un luogo a libero accesso, o che se i pannelli fanno passare la luce non lavorano, e questo è in sé un danno ambientale, dato che riduce il Ritorno Energetico sull’Investimento Energetico – EROEI), come la sostituzione di colture con terreni incolti (che fa uscire dal campo definitorio dell’agrivoltaico). E quelle di compensazione, se pure con una definizione anomala.
Può spiegare la parte strettamente agronomica? Da quanto ha spiegato online, è richiesto di selezionare specie adatte alle condizioni specifiche di insolazione (scoraggiando quelle ad elevato fabbisogno di radiazione solare come il mais, frumento e girasole), di stimare le rese (non tollerando cali di resa eccessivi) e, importante, critica la riconversione di colture di elevato valore (intensive) con altre di minor valore (seminative e prati pascolo). Infine, è incoraggiata la conservazione (o il ripristino a fine vita) di irrigazioni, canali, condotte idriche irrigue, opere minori, e via dicendo. Giusto?
Queste sono le indicazioni, ma tutte a titolo di esempio. Dunque, anche qui, si tratta di valutare caso per caso trovando il giusto equilibrio. Chiaramente l’insolazione, l’ombreggiamento, il microclima sono fattori decisivi sia per la produzione elettrica come per la produzione agricola. Qui va trovato un compromesso che tenga conto del valore ambientale preminente (per le normative europee) della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che deve essere sempre massimizzata a parità di superfice impegnata, e del valore in termini di quantità e qualità delle produzioni agricole. Le attuali definizioni di Agrivoltaico insistono, usando la nozione di “tassello” nelle Linee Guida 2022, per la compresenza di entrambe le produzioni sul medesimo suolo (e non, ad esempio, affiancate). Giusto o sbagliato (realizzammo in Sicilia un impianto ‘affiancato’ nel 2009, ed aveva il suo senso), è la norma. Dunque, si impone un compromesso. Aiuta avere una coltura che accetta l’ombra. Parimenti bisogna misurare le produzioni, che devono essere efficienti e non “testimoniali”. L’ultima citazione è in diretta contraddizione con un’altra sopra, quindi evidenzia il suo carattere di esempio, e non di prescrizione: o si prediligono colture intensive e di valore (qualunque cosa questo significhi, e non è chiaro), o si predilige i campi incolti, come poche pagine prima. La verità è che si deve decidere caso per caso.
Cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire scoraggiare coltivazioni come il frumento? Chi ha invece già incluso il frumento nel piano agronomico, cosa deve fare?
Il frumento è una coltivazione problematica, sotto un impianto agrivoltaico, ha bisogno di grandi spazi, macchine importanti e molto larghe, rotazioni colturali, e ha un rendimento francamente basso. In un luogo nel quale sono stati investiti mal contati un milione di euro per ettaro si può far meglio. Ciò detto, se lo ha fatto a ragion veduta e può difendere la sua scelta non deve fare nulla. Difenderla.
Le linee guida porteranno quindi ad un allungamento della fase progettuale dei progetti agrivoltaici? In quali casi? Soprattutto per quelli in via di conclusione? O in generale per tutti? E da quando?
A prenderle sul serio, queste Linee Guida portano a non meno di un anno di progettazione e un gruppo di lavoro di una decina di competenze diverse. Non tutti sono attrezzati e non tutti i progetti lo meritano. Ci sono anche casi semplici. Bisogna valutare ciò con cui si ha a che fare.
Lei spiega insomma che il documento alza significativamente l’asticella. Ma cosa succederebbe nel caso alcuni progetti non dovessero alzare appunto l’asticella? Quali sono i rischi per loro?
I rischi sono di essere respinti con l’argomento di non essere redatti conformemente alle Linee Guida, che ora ci sono. Bisognerebbe mostrare di averle lette e comprese, e, se del caso interpretate. Consiglierei di prenderle sul serio. Questa è ora la check list.
Altre considerazioni?
Queste Linee Guida sono utili, se lette con intelligenza dalle Amministrazioni. Pericolose, se lette come un elenco di cose da spuntare e delle quali riscontrare, semplicemente, la presenza o assenza. Ma ora servirebbe, per favore, l’aggiornamento delle Linee Guida Agrivoltaico del 2022.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.
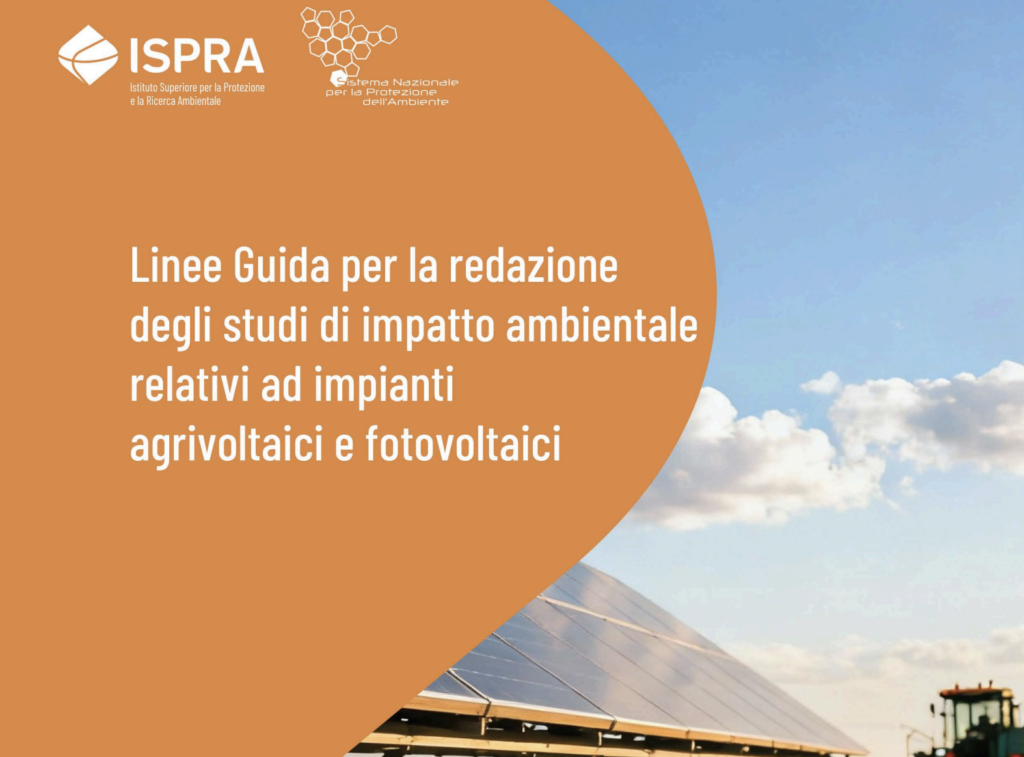
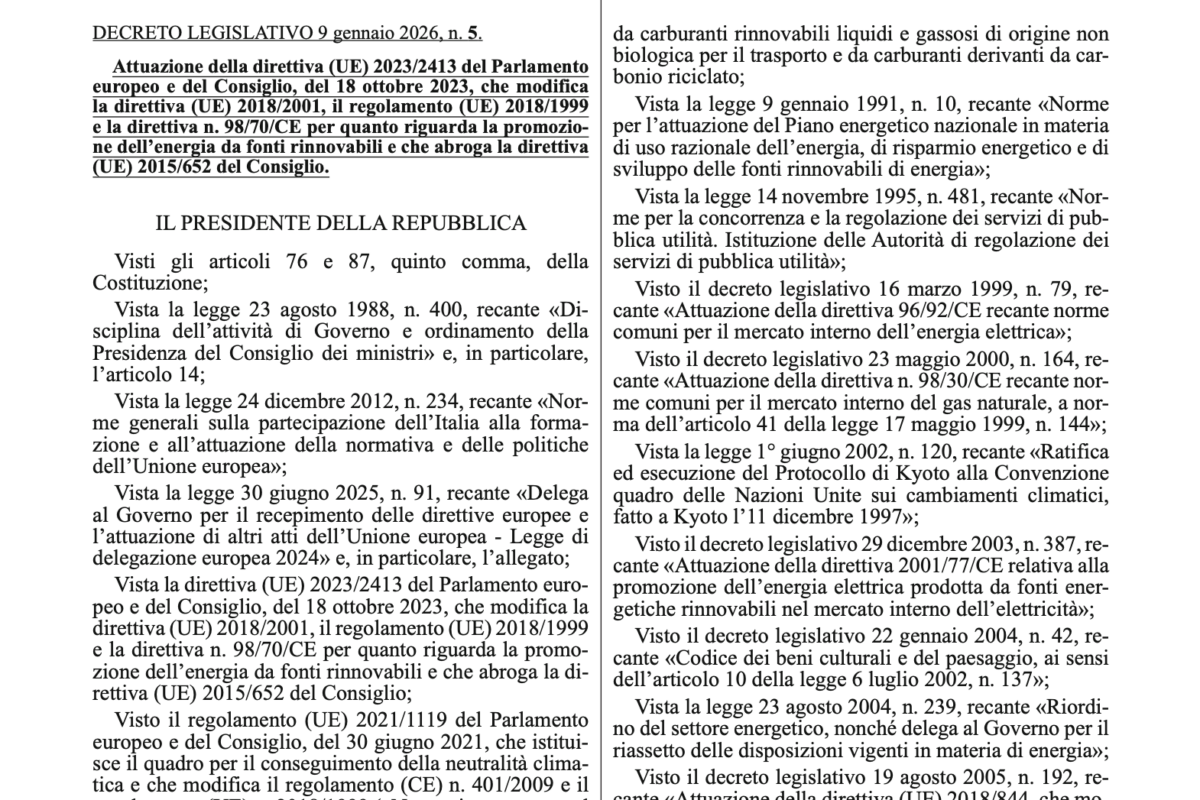





Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.