pv magazine Italia ha avuto il modo di capire dalla presidente di Aias, Alessandra Scognamiglio, dalla consigliera Aias, Valeria Viti, e dalla consigliera Agrivoltaica, Cristina Martorana, le conseguenze del Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175, sul mondo agrivoltaico. Martorana e Viti spiegano poi anche cosa succederà al meccanismo Transizione 5.0.
Nel Decreto Legge viene fornita una definizione di agrivoltaico. Cosa vuol dire? Che conseguenze potrebbe avere?
Alessandra Scognamiglio, presidente Aias: Bene che vi sia una definizione di agrivoltaico, e bene anche che la definizione che sia inclusiva e prestazionale. Tuttavia questa lascia un margine di ambiguità in merito al come possa essere effettivamente dimostrata in sede progettuale e di esercizio la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Questa ambiguità, che è stata già motivo di un atteggiamento estremamente prudente da parte dei decisori e del mondo agricolo, va risolta con opportune ulteriori elaborazioni per rendere credibili i progetti e consentire una effettiva diffusione dell’agrivoltaico.
Valeria Viti, consigliera Aias: Cogliamo con favore il chiarimento fornito sulla compatibilità dell’agrivoltaico rispetto a limitazioni che a questo punto senza dubbio sono riferite unicamente al fotovoltaico a terra. Inoltre il distinguo rispetto a progetti PNRR e il rimando a una adeguata sopraelevazione suggerisce flessibilità. Vedremo come sarà interpretata in fase pratica e come si coniugherà questa ritrovata compatibilità con i limiti regionali per le SAU.
Cristina Martorana, consigliera Agrivoltaica: L’art. 2 del Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante “Misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21/11/2025 e in vigore da sabato 22 novembre 2025 (Decreto Legge), stabilisce che al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, siano apportate le seguenti modificazioni (integrazioni): [….] «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.». Quindi sì, dopo una lunga latitanza, il Governo si è finalmente deciso a fornire al mercato rilevante una risposta su cosa si intenda per impianto agrivoltaico. E la cosa non è di poco conto dato che prima di oggi, in assenza di previsioni certe, era il spesso prevalsa la tendenza a qualificare come impianto agrivoltaico solo quello (super) avanzato, opportunamente e dettagliatamente descritto nelle Linee Guida Ministeriali del 27 giugno 2022, senza adeguatamente soppesare il fatto che le relative caratteristiche erano state delineate non per tutti i progetti agrivoltaici ma solo per quelli che volevano avere accesso agli incentivi e ai fondi PNRR.
Oggi il legislatore ha di contro messo in evidenza l’importanza del cuore dell’agrivoltaico, sottolineando che ciò che conta per distinguere quest’ultimo da un impianto solare a terra su area agricola è la necessità (per il primo) di preservare (e garantire) la continuità con l’attività agricola e pastorale. Requisito imprescindibile che, questo sì, deve essere interpretato in senso restrittivo e valutato alla luce delle migliori tecniche agronomiche e agropastorali, volte a garantire che di impianto agrivoltaico realmente si tratti, ma niente più. Il tutto in un contesto in cui, se ci riflettiamo, la definizione data non costituisce una novità in senso assoluto. Invero già l’art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies del DL n. 1/2012, prevedeva che : 1-quater: “Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”. Solo che, mentre tale previsione ed il comma seguente, erano volti ad identificare una tipologia di impianto che potesse accedere ad incentivo quando all’epoca l’accesso agli impianti solari a terra su area agricola era precluso, e non era stata in grado (in assenza di posizioni chiare) di emanciparsi dalla definizione di agrivoltaico avanzato, perché quello era l’unico che prevedeva una esplicita definizione anche delle altezze dei moduli, adesso la definizione data dal legislatore, alla luce dell’incipit della stessa disposizione, è più asettica e aperta. La portata di questo cambiamento, se correttamente interpretato, è in questo senso epocale anche perché ha un impatto su tutti i procedimenti autorizzativi pendenti e potrà valere come canone interpretativo per valutare la “bontà ” degli impianti agrivoltaici autorizzati che non abbiano avuto accesso agli incentivi.
Il Decreto Legge non contiene infatti una norma che disciplini il transitorio e per questo si applica automaticamente a tutti i procedimenti autorizzativi pendenti lasciando la possibilità agli operatori, sussistendone i presupposti, di adeguare il progetto alla nuova definizione di agrivoltaico. E non solo. La stessa definizione sembrerebbe, ma il condizionale è d’obbligo, porre fine alla diatriba che si era aperta a valle del DL Agricoltura che, con la sua infelice formulazione, aveva costretto gli operatori più prudenti ad includere l’agrivoltaico cosiddetto standard o base tra gli impianti che erano finiti nella tagliola del decreto stesso. Il tutto in un contesto in cui il legislatore di oggi non ha fatto peraltro niente di più che rendere esplicito ciò che la stessa giurisprudenza già aveva invece ben esplicitato quando aveva definito l’agrivoltaico quale “settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. […] Non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura” (Consiglio di Stato, sez IV, 8235/2023).
Come sempre tuttavia il nuovo contesto normativo non è esente da possibili dubbi interpretativi e da sorprese dato che lo stesso legislatore, dopo aver dato una chiara ed incontrovertibile definizione di impianto agrivoltaico, al comma 2 dell’articolo 2 prevede che “L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”.
La sorpresa è evidente dato che il legislatore ha qui riproposto il testo del DL Agricoltura, che ricordiamo è sub iudice avanti alla Corte Costituzionale. Lo ha riproposto con l’aggiunta dell’inciso finale di apertura all’agrivoltaico per come definito nel Decreto Legge. Cosa ci ha voluto dire con questa apertura il legislatore? Ha voluto chiarire i ricordati dubbi emersi a valle dell’approvazione del DL Agricoltura? Ha voluto solo ribadire la differenza tra impianti solari a terra e impianti agrivoltaici? Non è dato di sapere. Al momento non ci resta che aspettare la norma di conversione e confidare in una illuminata interpretazione e implementazione della disposizione in conformità allo spirito legislativo che appare sotteso alla definizione di agrivoltaico: valorizzare il cuore e lo scopo dello stesso e cioè quello di garantire la continuità e la preservazione dell’attività agricola e pastorale, dando decisamente meno risalto alle famose altezze.
Che conseguenze avrà il decreto sulle regioni che hanno già adottato misure sulle aree idonee?
Viti: Le regioni dovranno adeguarsi alla nuova disciplina e individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle già oggetto di indicazione da parte del Governo. Se da una parte il Decreto introduce un argomento ulteriore per ritenere illegittima la legge sarda in merito alle aree idonee, su cui si attende la Corte Costituzionale, dall’altra l’assenza di una disciplina transitoria, circostanza che il TAR Lazio ha stigmatizzato con sentenza rispetto al precedente Decreto, rischia di generare nuova entropia su un settore troppo fortemente inciso da regolazioni a singhiozzo, periodiche e frammentate. Auspichiamo che la conversione in Legge porti a più miti consigli e preservi le iniziative in itinere, su cui sono stati pianificati investimenti, peraltro contando anche su interpretazioni del Mase a specifici interpelli che sono integralmente travolte dalla nuova disciplina.
Martorana: Come ricordato si tratta di una previsione che potrebbe essere emendata o integrata in sede di conversione. Ciò doverosamente premesso, trattandosi comunque di una norma valida e pienamente efficace nella sua portata attuale, possiamo affermare che da oggi le regioni ed i comuni dovranno adeguarsi alla “nuova” definizione di agrivoltaico nel valutare i progetti sottoposti alla loro attenzione. Non sarà per loro necessario emanare una norma ad hoc, potendo semplicemente rinviare al testo previsto dal Decreto legge, ma di certo dovranno rivedere le previsioni più restrittive o limitanti che avessero nel frattempo emanato. Potrebbero invece sopravvivere, in tutto o in parte, le linee guida agronomiche e agropastorali regionali qualora fossero state emanate per valutare la bontà dei progetti. Il tutto nel parzialmente mutato contesto di definizione delle aree idonee, nell’ambito del quale le Regioni conservano il potere di stabilire quali saranno quelle idonee all’agrivoltaico, in che termini percentuali rispetto al loro territorio ed entro quale potenza.
Lo schema del nuovo DL approvato anticipa al 27 novembre l’invio delle domande di partecipazione al piano Transizione 5.0. Cosa vuol dire per il meccanismo in generale? Cosa vuol dire per le società che ne sono parte/ne vogliono essere parte?
Viti: Si tratta di un’anticipazione indotta dalla necessità di evitare duplicazioni fra la misura 4.0 e quella 5.0 tanto che nel testo viene precisato anche il significato del divieto di cumulo fra le due Transizioni.
Martorana: Il Piano Transizione 5.0 è un’iniziativa del governo italiano per sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese, prevedendo un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025, con una dotazione finanziaria complessiva di 12,7 miliardi di euro.
Per le società che ne sono parte o vogliono esserlo, il Piano Transizione 5.0 offre:
- Opportunità di investimento: possibilità di investire in tecnologie innovative e ridurre i consumi energetici.
- Credito d’imposta: possibilità di ottenere un credito d’imposta per gli investimenti effettuati.
- Semplificazioni procedurali: possibilità di inviare le comunicazioni preventive e di completamento in modo digitale.
Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono:
- Effettuare investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.
- Raggiungere obiettivi di risparmio energetico attraverso la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.
- Inviare la comunicazione preventiva al GSE, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione e gli investimenti agevolabili.
La previsione contenuta nel nuovo decreto legge deve essere positivamente accolta dal mercato dato che apre i tempi per la presentazione delle istanze al 27 novembre 2025 concedendo tempo fino al 6 dicembre per sanare le pratiche incomplete (ma non laddove manchi la certificazione energetica). Entro il 27 novembre le imprese dovranno anche decidere tra Transizione 4.0 e 5.0, fermo restando che “in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa (il riferimento è a Transizione 5.0) previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso” a Transizione 4.0.
Per quale motivo è stata presa questa decisione di anticipare il termine ultimo?
Viti: Con ogni probabilità, per consentire al GSE un’istruttoria completa delle domande che si sono rivelate di molto superiori alle attese.
Martorana: Sono stati costretti a farlo a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. L’obiettivo che si è prefissato il Governo è quello di garantire che le imprese che avevano già presentato domanda o che l’avrebbero presentata entro la nuova scadenza potessero avere accesso ai benefici residui prima della chiusura definitiva del piano. La scadenza è stata inoltre fissata per permettere la gestione dell’altra questione, già ricordata, relativa alla scelta tra fruire della misura Transizione 4.0 o a quella 5.0. La nuova scadenza, pertanto, oltre a far decidere le imprese la misura cui avere accesso, mira a garantire che le imprese in possesso dei requisiti possano accedere ai fondi rimanenti, anche se in quantità limitata.
Per il 2025 viene stanziato un importo pari a 250 milioni di euro per sostenere le domande presentate al piano Transizione 5.0. Questi sono fondi aggiuntivi? Riusciranno a coprire la domanda?
Viti: I fondi sono aggiuntivi, se saranno sufficienti però è presto per prevederlo.
Martorana: Come noto, le risorse disponibili per il 2025 sono esaurite. Le imprese che hanno presentato domanda dopo l’esaurimento delle risorse sono state messe in lista d’attesa. Il finanziamento di 250 milioni di euro menzionato potrebbe essere relativo a un accordo specifico con un ente finanziatore per supportare le imprese nella transizione digitale ed energetica, ma non è chiaro se questi fondi siano aggiuntivi o facciano parte della dotazione complessiva del Piano Transizione 5.0. In ogni caso, le imprese che intendono partecipare al piano devono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, o attendere la disponibilità di nuove risorse.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.
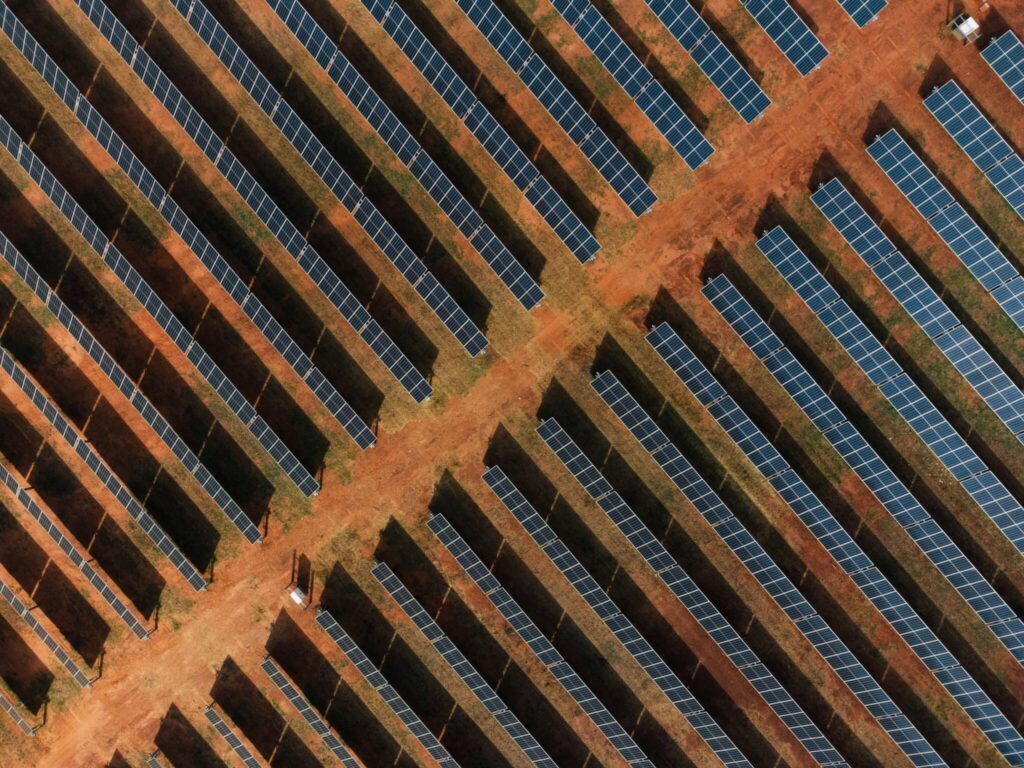






Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.