Nello scenario contemporaneo dell’architettura sostenibile si colloca l’integrazione del fotovoltaico negli edifici, considerata in modo accorato una delle sfide più attuali, interessanti e innovative, in grado di pesare in modo sostanziale sui temi dell’energia e dell’estetica urbana. Partendo da questo spunto, pv magazine Italia ha intervistato Marco Piva, architetto italiano di fama internazionale, fondatore dello Studio Marco Piva a Milano.
Fotovoltaico integrato negli edifici. C’è, secondo lei, un valore architettonico aggiunto di questa tecnologia?
Il fotovoltaico integrato non rappresenta solo una soluzione energetica sostenibile, ma anche un linguaggio architettonico contemporaneo. La sua integrazione nelle superfici edilizie come facciate, coperture, parapetti o schermature solari, consente di ridefinire il rapporto tra tecnologia, materia e forma. Nel nostro progetto, in fase conclusiva, di una villa privata a Padenghe sul Garda, ad esempio, i pannelli fotovoltaici ricoprono tutto il tetto e le pensiline e sono stati pensati già in fase iniziale, per far emergere la profonda sinergia tra architettura e contesto. I pannelli sono stati infatti posizionati in modo da integrarsi con l’architettura, sia in termini cromatici che dimensionali, per non essere percepiti: una scelta tecnologica ed impiantistica che riflette una chiara filosofia ecoarchitettonica, per unire architettura, paesaggio ed energia in un nuovo equilibrio tra uomo, natura e costruito.
Quindi il fotovoltaico come elemento di progetto?
Esatto. Il fotovoltaico diventa elemento di progetto quando partecipa alla definizione dell’immagine con coerenza estetica, della funzione e del significato dell’edificio, diventando una materia dell’architettura contemporanea e non un impianto “aggiunto”. In questo modo la tecnologia non “si aggiunge”, ma plasma forma, materiali e percezione dell’architettura.
Quali criteri considera prioritari quando si pianifica l’integrazione di moduli fotovoltaici in facciata o in copertura?
I criteri prioritari riguardano tre ambiti complementari: prestazionali, architettonici e costruttivi. l’integrazione del fotovoltaico richiede una sintesi tra efficienza energetica, coerenza architettonica e correttezza costruttiva. Solo bilanciando questi tre livelli la tecnologia diventa parte organica dell’architettura e non mero dispositivo tecnico.
Oltre al progetto sul Garda, può raccontarci progetti in cui l’integrazione architettonica del fotovoltaico si è rivelata particolarmente efficace?
Nel complesso residenziale Princype a Milano, un intervento di rigenerazione urbana del nostro Studio che ha colmato un vuoto urbano con un edificio contemporaneo pensato per ridurre al massimo i consumi energetici. La facciata principale, con parete ventilata ricoperta in gres, riduce fino al 30% il fabbisogno di energia rispetto ad altri sistemi costruttivi, mentre l’unione di pompe di calore condensate ad acqua di falda con l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio garantisce il 65% del fabbisogno previsti per il riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria dell’intero edificio. Si tratta di un edificio “intelligente”, sostenibile e durevole nel tempo, con accorgimenti di fatto necessari oggi, dove il progettista deve saper attuare soluzioni indispensabili per definire un nuovo patto con il Pianeta, come è successo anche per i complessi residenziali Syre ed Easy a Milano.
Può entrare nel dettaglio?
L’adozione di impianti fotovoltaici è stata integrata fin dalle prime fasi della loro progettazione. Il termine dei lavori è previsto per la prossima primavera per l’edificio Syre e dicembre 2025 per edificio Easy. Gli impianti sono installati sia sul corpo alto del tetto di Easy, edificio di edilizia sociale tra i 6 e i 9 piani fuori terra, che sul corpo basso (denominato LCB) del tetto di Syre, edificio di 6 piani destinata all’edilizia libera, con l’obiettivo di promuovere un modello abitativo sostenibile e a basso impatto energetico. L’impianto in corso di realizzazione in copertura di LCB avrà potenza di circa 118kW, invece, l’impianto in corso di realizzazione in copertura di Easy avrà potenza di circa 20 kW entrambi realizzati grazie all’installazione di moduli fotovoltaici total black. Questo approccio conferma come anche l’edilizia sociale stia evolvendo verso soluzioni innovative e sostenibili, superando il tradizionale concetto di “casa popolare” per diventare parte integrante di una nuova visione urbana attenta alla qualità, all’efficienza e all’ambiente.
Invece, un esempio internazionale che considera particolarmente ispirante per l’uso integrato del fotovoltaico?
L’Apple Park, sede del colosso informatico a Cupertino, USA. Il tetto ad anello del suo campus, completamente coperto da pannelli solari integrati, è sicuramente un modello di integrazione tra sostenibilità ed estetica, tra forma e funzione.
Sta cambiando la sensibilità dei committenti verso le soluzioni solari integrate?
Oggi i committenti sono molto più sensibili: iniziano a vedere il fotovoltaico non solo come un impianto tecnico, ma come parte dell’architettura. C’è più attenzione al valore estetico, alla sostenibilità e all’immagine dell’edificio. Restano alcune resistenze legate ai costi e alla complessità, ma la cultura sta cambiando rapidamente.
Quali sono le criticità tecniche o estetiche più frequenti che si incontrano nel dialogo tra architettura e fotovoltaico?
La più comune è quando il fotovoltaico viene “aggiunto” a progetto finito: si perde coerenza formale e si crea un effetto posticcio. Poi ci sono problemi tecnici come infiltrazioni, pesi, manutenzione, ma alla base c’è sempre la stessa cosa: mancanza di integrazione progettuale. Quando architetto e ingegnere lavorano insieme dall’inizio, le criticità si trasformano in opportunità. L’estetica si concilia con l’efficienza energetica attraverso il progetto, non con il compromesso. Oggi l’estetica nasce proprio dall’efficienza: materiali, luce, orientamento e tecnologia diventano parte del linguaggio architettonico. La sostenibilità non è più un vincolo tecnico, ma un principio compositivo che dà forma a un’estetica nuova, autentica e coerente con il nostro tempo.
E qui, per la diffusione del BIPV in Italia, entrano in gioco i materiali innovativi come i vetri fotovoltaici o le tegole solari…
Esatto, hanno un ruolo fondamentale. Questi materiali rendono il BIPV più flessibile e più facilmente integrabile nei progetti architettonici, anche in contesti storici o residenziali e permettono di unire tecnologia e linguaggio architettonico, superando il limite estetico dei pannelli tradizionali. In questo modo il fotovoltaico diventa più accettato, più visibile e quindi più diffuso.
Cosa manca, ad oggi, per favorire una reale diffusione del fotovoltaico integrato nel settore edilizio italiano?
In Italia, la diffusione del fotovoltaico integrato è in effetti ancora limitata, nonostante il grande potenziale del Paese. Le difficoltà derivano da una combinazione di fattori normativi, economici, culturali e tecnici. Le norme attuali trattano il fotovoltaico integrato come un semplice impianto e non come parte dell’edificio, con conseguenti iter autorizzativi complessi. Sul piano economico, mancano inoltre incentivi specifici, avendo un costo comunque elevato se ci sono limitazioni di budget è uno dei primi aspetti a “saltare”. A queste criticità si aggiunge a mio avviso anche un limite culturale dei committenti, che lo percepiscono come un’aggiunta tecnica piuttosto che come elemento del linguaggio architettonico, in grado di influire inoltre sulla qualità ambientale
Per favorire una reale diffusione servirebbe un approccio coordinato che includa regole chiare, incentivi dedicati, formazione specifica, e una maggiore collaborazione tra architettura, ingegneria e industria, come dicevo prima. Manca una visione sistemica che renda l’energia parte integrante dell’architettura.
Come immagina l’evoluzione dell’architettura energetica nei prossimi dieci anni
È destinata a trasformarsi profondamente, passando dall’idea di “edificio che consuma meno” a quella di edificio che produce, scambia e gestisce energia in modo intelligente. Non si parlerà più soltanto di efficienza, ma di ecosistemi edilizi attivi, capaci di dialogare con le reti, l’ambiente e le persone. Da tempo nel mio Studio ho attivato un concept progettuale che ho chiamato “Green Wave”, un nuovo modo di concepire gli spazi esterni urbani: terrazze, coperture e cortili sono reinterpretati come estensioni vitali dell’abitare contemporaneo, luoghi di socialità e benessere che uniscono architettura, natura e tecnologia. L’idea nasce dalla constatazione che nelle città esiste un patrimonio enorme di superfici inutilizzate, tetti, lastrici solari, terrazze, che possono diventare nuovi spazi di relazione e micro‐ecosistemi verdi, capaci di migliorare il comfort abitativo e ridurre l’impatto ambientale.
Quindi, andando ben oltre il concetto di arredo urbano?
In questa visione, l’energia diventa parte del paesaggio urbano sostenibile: le superfici verdi e fotovoltaiche si fondono in un’ “onda verde” che, diffondendosi sui tetti e sulle facciate della città, crea una rete di spazi abitabili, produttivi e rigenerativi. La risposta è sì, Green Wave non è solo un progetto di arredo urbano, ma un modello di architettura energetica diffusa, dove estetica, comfort e produzione rinnovabile convivono in equilibrio. L’architettura del prossimo decennio sarà quindi sempre più interattiva e sensibile al contesto: edifici che reagiscono al clima, che ottimizzano luce, calore e ventilazione in tempo reale, e che comunicano i propri flussi energetici attraverso interfacce visibili. La sostenibilità non sarà più un “tema aggiunto”, ma un fattore estetico e identitario: la forma stessa dell’edificio racconterà la sua efficienza e la sua relazione con il sole, il vento e il territorio.
I punti di vista e le opinioni espressi nel presente articolo sono quelli dell’autore e non riflettono necessariamente quelli di pv magazine.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.


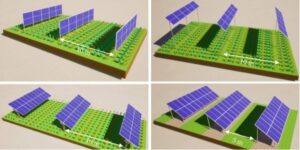




Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.